Dedicato ai “cultori” dello Sport
Charles Pierre de Frédy, barone di Coubertin, noto come Pierre de Coubertin, nato a Parigi il 1° gennaio 1863 e mancato a Ginevra il 2 settembre 1937, è stato uno dirigente sportivo, un pedagogo, e uno storico francese ma soprattutto conosciuto quale “fondatore” dei Giochi Olimpici moderni.
Nacque in una famiglia aristocratica e, in seguito ad alcuni viaggi in Inghilterra ebbe modo di conoscere i principi educativi di Thomas Arnold, che influenzarono notevolmente il suo pensiero, e iniziò quindi a proporre “lo sport e l’esercizio fisico” quali elementi pedagogici negli istituti scolastici. Contribuì alla creazione di alcune associazioni come l’Union des sociétés francaises de sport athletiques e si impegnò nel progetto di rinascita degli antichi giochi di Olimpia.
Le sue idee si concretizzarono con la fondazione delle Olimpiadi moderne nel corso del Congresso Olimpico del 1894, in cui fu affidata ad Atene l’organizzazione dei Giochi della 1° Olimpiade nel 1896, data n cui venne costituiti anche il 1° Comitato Olimpico Internazionale. Nel corso della sua Presidenza di tale Ente, terminata nel 1925 istituì alcuni simboli che sarebbero diventati fondamentali nel contesto sportivo, tra cui il il “motto olimpico” – Citius, Altius, Fortius – la bandiera a cinque cerchi e il giuramentoi. Fu inoltre promotore della nascita dei Giochi Olimpici Invernali, con la 1ma edizione a Chamonix nel 1924. In ambito educativo costituì l’Eclairesus Francais, la prima organizzazione scout francese.
Ebbe anche una prolifica carriera letteraria, spaziando da trattati sportivi a opere educative, da testi storico-politici ad autobiografie; tra i 34 libri pubblicati figurano L’Evolution Française sous la Troisième République (1896), Histoire universelle (1920), Leçons de Pédagogie sportive (1921) e Mémoires olympiques (1932). Conquistò anche una medaglia d’oro per la letteratura alle Olimpiadi del 1912 con la poesia “Ode allo sport”.
Nel 1936 il CIO lo propose per il Premio Nobel per la pace con la motivazio “per i suoi sforzi nella riduzione delle tensioni mondiali attraverso la rinascita e l’organizzazione dei Giochi olimpici internazionali.”
Il 2 settembre 1937, durante una passeggiata nel parco La Grange di Ginevra, Pierre de Coubertin fu colpito da un infarto e morì all’età di 74 anni. Il suo corpo fu tumulato nel Cimitero di Bois-de-Vaux di Losanna, che aveva nominato il fondatore delle Olimpiadi modernebourgeois d’honneur (“cittadino onorario”) due mesi prima. Rispettando le sue ultime volontà, il suo cuore fu imbalsamato e portato presso le rovine di Olimpia nel marzo 1938, dove venne posto in un’urna di bronzo sigillata poi in una stele di marmo bianco, che era stata inaugurata in sua presenza nel 1927 per commemorare la rinascita dei Giochi Olimpici.
Dopo la sua morte, gli furono dedicati vari monumenti e onorificenze sportive, tra cui la medaglia Pierre de Coubertin.
Qualche cenno a partire del suo pensiero.
«L’important dans la vie ce n’est point le triomphe, mais le combat, l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu.»
«L’importante nella vita non è il trionfo ma la lotta. L’essenziale non è aver vinto, ma aver lottato bene.»
«Wars break out because nations misunderstand each other. We shall not have peace until the prejudices that now separate the different races are outlived. To attain this end, what better means is there than to bring the youth of all countries periodically together for amicable trials of muscular strength and agility?»
«Le guerre scoppiano perché le nazioni si fraintendono a vicenda. Non avremo pace finché non saranno superati i pregiudizi che ora separano le diverse razze. Per raggiungere questo scopo, quale mezzo migliore se non quello di riunire periodicamente i giovani di tutti i paesi per competizioni amichevoli di forza muscolare e agilità?»
Malgrado appartenesse da generazioni alla nobiltà, considerò sempre lo sport come importante strumento sociale che avrebbe favorito i valori della democrazia. Le competizioni avrebbero quindi consentito agli atleti di superare i confini di classe senza tuttavia provocarne commistioni, guardate con avversione dal pedagogo francese. Ebbe poi in particolare considerazione gli sort di squadra in quanto favorivano la collaborazione tra persone diverse per il raggiungimento di un obiettivo comune, apprezzando in particolare il ruolo comunitario del “Calcio” da lui definito “gioco magnifico che ha propiziato non solo lo sviluppo muscolare ma anche quello sociale“. L’idea di proporre un’educazione sportiva migliore per chi eccelleva nelle competizioni, seguendo valori vicini a quelli della Terza Repubblica, fu il tema di un dibattito pedagogico incluso nel “Le sport contre l’éducation physique” di Georges Hèbert del 1925, che vedeva i suoi ideali contrapposti ai sostenitori dell’esercizio fisico come attività prettamente militare, tra cui Paul Bert e coloro che auspicavano un’educazione sportiva sempre egualitaria e collettiva per il maggior numero di persone, come Paschal Grousset.
Ma la sintesi di tutti i suoi ideali pedagogici e sportivi si espresse concretamente con la rinascita dei Giochi Olimpici, che rappresentò di fatto il “sogno della sua vita”. Più volte identificò l’antica Olimpia come sua fonte di ispirazione per gli eventi olimpici moderni, facendo anche riferimento a una sorta di “dimensione spirituale” che avrebbe contraddistinto tali manifestazioni dagli altri eventi sportivi. Quando iniziò a sviluppare la sua teoria riguardante l’educazione fisica, il nobile prese come modello l’idea ellenica del ginnasio, una struttura che educava alla vita attiva attraverso la pratica agonistica e incoraggiava lo sviluppo fisico degli sportivi greci secondo “la religione dell’esercizio atletico” con un parallelismo tra passato e presente, de Coubertin disse “così come l’antico atleta onorava gli dei cesellando il suo corpo attraverso l’esercizio come uno scultore fa con le statue, l’atleta moderno onora il proprio paese”. Cercando di rendere il più attuale possibile l’antica tradizione sportiva di Olimpia senza tuttavia snaturarne la forma, si impegnò per mantenerne la componente “intellettuale”, “morale” e “religiosa”, aggiungendo a questi tre aspetti l’internazionalizzazione delle competizioni e i miglioramenti tecnici relativi allo sport e in generale alla società civile.
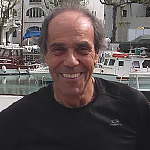
A cura di Pier Luigi Cignoli – Foto ImagoEconomica








