L’Epifania (nome completo: Epifania del Signore), nota anche come Festa dell’Epifania o Santa Teofania nell’Oriente cristiano, è una festa che si celebra il 6 gennaio di ogni anno per commemorare la manifestazione (teofania) di Gesù Cristo come Dio figlio incarnato. Nel cristianesimo occidentale, commemora principalmente la visita e l’adorazione dei Magi al Bambino Gesù, e quindi la manifestazione fisica di Gesù Cristo aiGentili. Mentre in Oriente ricorda il battesimo di Gesù nel fiume Giordano e il miracolo delle nozze di Cana.
Fa parte del periodo natalizio.
In molte Chiese occidentali, la vigilia della festa è celebrata come la 12ma notte di Natale, è l’ultimo giorno del tempo di Natale e una delle più antiche festività cristiane (insieme a Pasqua e Pentecoste). E’ chiamata anche il Giorno dei Re Magi e in alcune tradizioni viene celebrata come Piccolo Natale. Inoltre, la festa dell’Epifania, in alcune denominazioni, dà inizio ad un periodo dell’anno liturgico chiamato “Tempo dell’Epifania“.
Nelle Chiese orientali l’evento celebrato è il battesimo di Gesù, momento in cui Gesù adulto viene manifestato come Figlio di Dio dalla voce del Padre e dalla colomba dello Spirito Santo. La data della festa è il 6 gennaio per le Chiese che seguono il Calendario Gregoriano e il 19 gennaio per quelle che adottano il Calendario Giuliano.
Le usanze popolari dell’Epifania includono il “Canto dell’Epifania“, la “Benedizione del gesso e della casa“, il consumo della “torta dei Re Magi“, il “bagno invernale“, il “falò d’inizio anno” e la partecipazione a funzioni religiose. È consuetudine per i cristiani in molte località rimuovere le loro decorazioni natalizie alla vigilia dell’Epifania (dodicesima notte), sebbene in altri paesi cristiani storicamente si rimuovano il 7 gennaio o alla Candelora, la conclusione dell’Epifania.
Il termine “epifania” deriva dal greco antico, verbo epifàino (ἐπιφαίνω, che significa “mi rendo manifesto“), dal sostantivo femminileepifàneia (ἐπιφάνεια, traducibile con “manifestazione”, “apparizione”, “venuta”, “presenza divina”).
Fin dai tempi di Giovanni Crisostomo il termine assunse una valenza ulteriore, associata alla natività di Gesù. Nelle Chiese “cattolica – ortodossa – anglicana” è una delle massime solennità dell’anno liturgico, come la Pasqua, il Natale e la Pentecoste, e per i Cattolici è festa di precetto; negli stati in cui non è riconosciuta come festività civile, viene spostata alla domenica tra il 2 e l’8 gennaio. È l’ultima delle solennità del tempo di Natale. Un vecchio proverbio recita: “L’Epifania tutte le feste porta via!“
È chiamata impropriamente con il termine profano “Befana” (corruzione lessicale di Epifania, dal grecoἐπιφάνεια, epifáneia, attraverso bifanìa e befanìa), figura folcloristica tipica di alcune Regioni Italiane e diffusasi poi in tutta la penisola, in quanto associata alla “Vecchia” che, cavalcando una scopa, porta i regali ai bimbi.
Storia
Il termine ἐπιφάνεια veniva già utilizzato dagli antichi greci per indicare l’azione o la manifestazione di una qualsiasi divinità (mediante miracoli, visioni, segni, ecc.). È la manifestazione della luce, della Luce più grande di Dio che si manifesta attraverso una stella. È usuale in molte parti del mondo augurarsi Buona Pasqua Epifania.
Tito Flavio Clemente di Alessandria, un padre della Chiesa, che scrive alla fine del II secolo, attesta che le comunità cristiane della sua grande città formate dallo gnostico Basiliade (i “Basilidiani”) celebravano il battesimo di Gesù Cristo, e con esso anche l’Epifania come la “manifestazione del Signore al mondo“, il 15º giorno del mese di Tybi dell’antico Calendario Alessandrino, che corrisponderebbe al nostro 6 gennaio.
Per l’interpretazione di questo passo occorre ricordare che il battesimo di Gesù, l’Epifania e l’annuncio degli angeli ai pastori in occasione della nascita erano festeggiati simultaneamente come manifestazioni della divinità di Gesù. Ciò era facilitato da alcune varianti del Vangelo di Luca, dalle quali il battesimo sembra aver avuto luogo nello stesso giorno della nascita. A partire dal III secolo circa, le comunità cristiane del Vicino Oriente associarono il termine Epifania ai tre segni rivelatori di Gesù Cristo, e cioè: l’adorazione dei Magi, il battesimo di Gesù adulto nel fiume Giordano e il primo miracolo di Gesù avvenuto a Cana.
Tuttavia, i primi cristiani di Gerusalemme non festeggiavano il Natale il giorno 25 dicembre: un documento chiamato “Itinerarium“, opera della pellegrina Egeria, narrerebbe la suggestiva presenza di vescovi cristiani in visita a Betlemme la sola notte del 6 gennaio, più otto giorni di celebrazioni liturgiche successive a questa stessa data, e una festa della Resurrezione di Cristo in primavera. Tuttavia la separazione tra la ricorrenza della adorazione dei Magi nella Natività e la ricorrenza del Battesimo di Gesù fu probabilmente fatta per non accavallare le date dei pellegrinaggi che partivano per il fiume Giordano e contemporaneamente presso Betlemme. Comunque, le considerazioni di Giovanni di Nikiu influenzarono Cirillo di Alessandria d’Egitto, per cui anche le prime comunità Copte cominciarono a celebrare la Natività il giorno 25 dicembre.
Giovanni Crisostomo
Nel 386 Giovanni Crisostomo, in contrasto alle ricorrenze giudaiche, sostenne fermamente la celebrazione del Natale al 25 dicembre. Pertanto, sia le comunità cristiane di Antiochia, quindi della Tracia e dell’Anatolia, si adeguarono a tale data. La convinzione, forse forzata, dello stesso Crisostomo fu quella che, a sua interpretazione arbitraria dei Vangeli, il Battista fu concepito in settembre, pertanto Gesù, di sei mesi più giovane, fu concepito a marzo, e quindi nacque in dicembre. Tuttavia, alcuni storici come Erbes, darebbero le date liturgiche separate del Natale e dell’Epifania già come tacitamente pre-accordate già durante il Concilio di Nicea del 325. Certo è che, sia Giovanni Crisostomo, sia un altro famoso Padre della Chiesa, Girolamo, sostennero che, se il Signore si manifestò in Gesù bambino a Betlemme, Egli si rese veramente pubblico trent’anni dopo, nel Gesù adulto del Giordano. Pertanto, già sul finire del IV secolo, adorazione dei Magi e Battesimo di Gesù divennero due ricorrenze separate.
Epifanio di Salamina
L’“Epifania” intesa come solo Battesimo di Gesù fu riconfermata dal teologo Epifanio di Salamina, uno dei Padri della Chiesa. Essa doveva ricadere 12 giorni dopo la ricorrenza del Natale, questo probabilmente per assorbire gli antichi simbolismi del numero 12 nei precedenti riti pagani del “Sol Invictus“.
Il problema delle date si restrinse solo più nell’adattamento ai vari tipi di calendari; un antico documento, ilCronografo del 354 di Furio Dionisio Filocalo, citava tutte le ricorrenze romano-cristiane dopo il Concilio di Nicea del 325 d.C., compresa l’Epifania; nel 46 però, Giulio Cesare aveva introdotto il Calendario Giuliano e, a causa di complessi calcoli, quello giuliano risultava sfasato esattamente di 13 giorni più avanti rispetto a quello più recente gregoriano, adottato nel mondo occidentale cattolico dall’anno 1582.
Invece, gli Ortodossi della Chiesa d’Oriente di rito Bizantino, chiamati anche “Cristiani Ortodossi di Vecchio Calendario (o di Calendario Giuliano)“, celebrano l’Epifania il 19 gennaio del nostro calendario, e la chiamano “Teofania” (manifestazione di Dio), mentre il “loro” Natale cade il 7 gennaio. Inoltre, la suddetta Teofania di Calendario Giuliano viene celebrata come la sola Commemorazione del Battesimo di Gesù nel Fiume Giordano. Per la Chiesa di rito romano, madre dell’attuale “Cattolicesimo”, l’Epifania doveva cadere il 6 gennaio del Calendario Gregoriano, commemorando la “manifestazione” del Signore attraverso il segno rivelatore dell’adorazione dei Magi a Betlemme, mentre il Battesimo di Gesù, invece, doveva essere separato, e cadere quindi nella domenica immediatamente successiva al 6 gennaio. Fu sempre nello stesso periodo che, per le sole Chiese romane, l’adorazione dei Magi fu fatta coincidere col 6 gennaio piuttosto che col 25 dicembre, sebbene le due ricorrenze commemorino sempre la stessa manifestazione di Betlemme.
Per alcuni paesi cristiani in cui l’Epifania non era istituita come festa di precetto, questa veniva celebrata il lunedì coincidente o successivo al 6 gennaio; nella “messa tridentina”, invece, il Battesimo di Gesù viene celebrato in un giorno fisso, detto l’ottava di Epifania (13 gennaio) e cioè 8 giorni dopo l’Epifania. La ricorrenza del Battesimo di Gesù conclude tutto il periodo natalizio dell’anno liturgico cattolico romano.
Sempre Epifanio di Salamina racconta il Battesimo di Gesù come la manifestazione della divinità: “Quando tutto il popolo si fu battezzato, venne anche Gesù e fu battezzato da Giovanni. E allorché uscì dall’acqua, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito Santo in forma di colomba che discendeva e penetrava in lui. E dai cieli venne una voce che disse: Tu sei il mio figlio diletto: in te mi sono compiaciuto. E poi ancora: Io oggi ti ho generato. E in quel momento una gran luce illuminò tutto il luogo. Vedendolo Giovanni gli disse: Tu chi sei? E di nuovo una luce dal cielo a lui: Questo è il mio figlio diletto in cui mi sono compiaciuto. Allora Giovanni gettandosi ai suoi piedi disse: Ti prego Signore, battezzami tu! Ma egli vi si oppose, dicendo: Lascia, perché così conviene si adempiscano le cose“.
Riguardo alla nascita di Gesù il testo dei Vangeli, come quello di tutte le altre opere di scrittori antichi, è il frutto di un lavoro storico, filologico e dottrinale che richiede delle scelte tra alternative differenti.
Ad esempio Epifanio cita un passo del Vangelo di Luca 3,22 diverso da quello riportato dalle attuali traduzioni della Bibbia; questa discrepanza è presente in vari codici, tra cui il “Codice Bazae“: le parole di Dio sono rese Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητό, εγὼ σήμερον γεγέννηκά σε (su ei huios mou ho agapetos, ego semeron gegenneka se, Tu sei il mio figlio prediletto, in questo giorno ti ho generato) al posto di ἐν σοὶ εὐδόκησα (en soi eudokesa, in te mi sono compiaciuto).
I Magi sono stati interpretati come Re Magi per l’influsso di Isaia 60,3, e sono stati attribuiti loro i loro nomi di Melchiorre (semitico), Gaspare (camitico) e Baldassarre (iafetico).
Secondo il Vangelo di Matteo (2,2) i Magi (non precisati nel numero), guidati in Giudea da una stella (ἀστέρα, da ἀστήρ, stella od astro), portano in dono a Gesù bambino, riconosciuto come “Re dei Giudei” (Mt 2,2: βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων), oro (omaggio alla sua regalità), incenso (omaggio alla sua divinità) e mirra (anticipazione della sua futura sofferenza redentrice) e loadorano.
Con l’Epifania si celebra la prima manifestazione della divinità di Gesù all’intera umanità, con la visita solenne, l’offerta di doni altamente significativi e l’adorazione dei Magi, autorevoli esponenti di un popolo totalmente estraneo al mondo ebraico e mediterraneo. Avvenimento di fondamentale importanza per la tradizione cristiana, che ha trovato riscontro in numerosissime opere d’arte.
Liturgia nelle Chiese orientali
Nelle Chiese cristiane ortodosse la festa è normalmente denominata “Teofania del Signore”, e commemora le diverse manifestazioni della divinità di Gesù Cristo, soprattutto il suo battesimo nel Giordano.
Nel “Rito Bizantino” le celebrazioni comprendono una veglia notturna, che comincia con i vespri solenni, prosegue con la “Divina liturgia di San Basilio”, una grande “compieta” la “litia” , il “mattutino”, la “Divina liturgia di san Giovanni Crisostomo” e una benedizione solenne delle acque, che può avere luogo sia in chiesa sia presso un corso d’acqua, sulle rive di un lago o al mare.
Dove invece è seguito il Calendario Giuliano, nel giorno corrispondente al 7 gennaio gregoriano si celebra la “Nascita di Gesù”, a causa di una differenza di tredici giorni fra calendario gregoriano, promulgato nel 1582, e il calendario giuliano precedente, ancora in uso in alcune Chiese ortodosse; di conseguenza l’Epifania è celebrata il 19 gennaio del calendario civile.
Nelle Chiese ortodosse che osservano il calendario gregoriano (con il calendario giuliano conservato per il solo ciclo pasquale), la Teofania è celebrata il 6 gennaio.
Nella Chiesa latina
Nel “Rito Romano” l’Epifania è parte del “tempo di Natale” e cade di norma il 6 gennaio e ha grado di solennità, come lo stesso Natale e il 1º gennaio, giorno di Maria santissima Madre di Dio. Nei paesi in cui l’Epifania non è festa di precetto, essa si celebra nella domenica che cade tra il 2 e l’8 gennaio.
Prima della “Riforma liturgica” di Papa Palo VI l’Epifania dava inizio al “Tempo di Epifania“, un periodo del calendario liturgico della durata di otto giorni, tuttora presente nella Chiesa Anglicana e in diverse Chiese Protestanti e comprendeva nelle seguenti domeniche e festività:
6 gennaio: Epifania del Signore: Ecce, advenit dominator Dominus;
Domenica dopo l’Epifania: festa della Sacre Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe: Exsultat gaudio pater Iusti;
13 gennaio: commemorazione del Battesimo di nostro Signore Gesù Cristo: Ecce, advenit dominator Dominus; quando il 13 gennaio cadeva di domenica, prevaleva la festa della Sacra Famiglia.
Nel “Rito Ambrosiano” con la festa ha inizio il Tempo di Epifania, che dura fino all’inizio della Quaresima e prevede la celebrazione di due ricorrenze legate all’infanzia di Gesù: la Sacra Famiglia nell’ultima domenica di gennaio (terza o quarta dopo l’Epifania) e la Presentazione del Signore il 2 febbraio.
Aspetti folcloristici e culturali dell’Epifania:
Nelle varie culture la celebrazione dell’Epifania si accompagna a simboli e tradizioni diverse di derivazione molto antiche (culti solari) frammiste a contaminazioni più recenti come:
la Stella di Betlemme che guida i Magi, riproposizione artistica di Giotto nell’affresco della Cappella degli Scrovegni della stella citata nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 2;
L’accensione di fuochi augurali (culti solari);
L’accensione dei falò la sera dell’Epifania o la sera precedente;
Le feste popolari;
La tradizione dei regali ai bambini e alle bambine (nella calza dove possibile messa al camino), soprattutto nei paesi di tradizione cattolica; in Italia, i doni sono portati dalla Befana (personificata da una vecchia brutta ma buona, legata secondo la tradizione all’adorazione dei magi). In Spagna e altre nazioni e/o regioni, fra cui tradizionalmente anche la Sardegna, i regali sono portati dai Re Magi;
L’uso, nella maggior parte dell’Europa, di preparare un dolce al forno con dentro la figurina di uno dei magi: spesso si nasconde la figurina e la persona cui capiterà il re, diventerà il re della giornata con particolari privilegi e obblighi (Galette des rois, Roscón de Reyes);
Alcuni riti legati all’acqua, secondo la tradizione orientale in cui il 6 gennaio si celebrava il Battesimo di Gesù: ad esempio, la tradizione nei paesi dell’Europa orientale di ripescare una croce di legno in acqua gettata da un pope, richiamo al battesimo dei cristiani, oppure la benedizione dell’acqua, del sale e della frutta in alcune zone anticamente dipendenti dal Patriarcato di Aquileia.
In Italia l’Epifania è una festa nazionale ed è associata alla figura della Befana (il cui nome è una corruzione della parola Epifania), un’anziana donna a cavallo di una scopa che, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, porta doni ai bambini o un pezzo di “carbone” (costituito da caramelle nere) per tutti i comportamenti cattivi tenuti durante l’anno. La leggenda raccontata di lei che, avendo perso l’occasione di portare un dono al bambino Gesù insieme ai Magi biblici, ora porta doni ad altri bambini in quella notte.
Tuttavia, in alcune parti dello stato italiano di oggi, esistono tradizioni diverse, e al posto della Befana sono i tre Re Magi a portare i doni. In Sardegna, ad esempio, dove convivono tradizioni e usanze locali del periodo ispanico, è particolarmente viva la tradizione dei Magi biblici (in lingua sarda: Sa Pasca de is Tres Reis) che portano doni ai bambini.
Grazie per il tempo che mi avete dedicato.
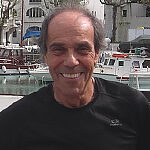
A cura di Pier Luigi Cignoli – Foto Repertorio








